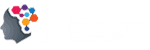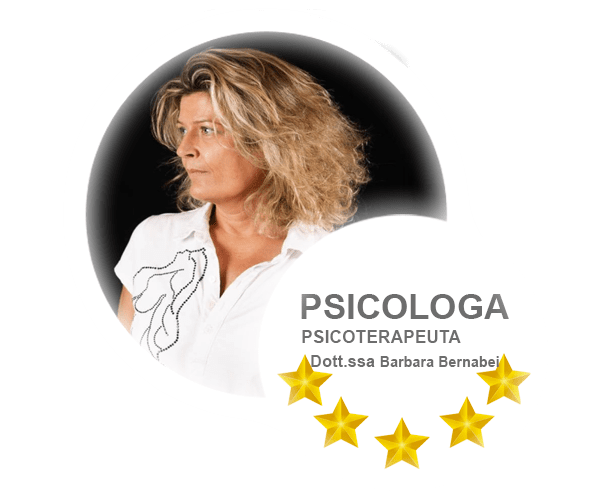L’evoluzione attraverso cui una persona sviluppa un disturbo da uso di sostanza è stato descritto come un processo a fasi, in cui inizialmente il soggetto ha un atteggiamento positivo nei confronti della sostanza che porta alla sua sperimentazione; successivamente, la persona inizia ad avere un uso della sostanza regolare attraverso la messa in atto di un comportamento impulsivo, fino ad arrivare al comportamento compulsivo dell’abuso e alla dipendenza. L’impulsività è intesa come un insieme di comportamenti e scelte, una predisposizione a reazioni rapide e non pianificate a stimoli, interni ed esterni, senza tener conto delle conseguenze negative di queste reazioni a se stessi o ad altri, viceversa la compulsione è intesa come un insieme di azioni perseveranti, ripetitive e reiterati, che sono eccessive e inadeguate in determinate situazioni. In questo modo l’impulsività viene identificata come un’inclinazione dell’individuo e degli animali al comportamento di dipendenza, mentre la compulsione supporta il mantenimento della condizione patologica legata all’uso da sostanza.
Ma cosa succede al nostro cervello quando utilizziamo una sostanza?
Le sostanze agiscono sul sistema nervoso centrale andando ad interferire con la trasmissione sinaptica (ovvero la comunicazione tra neuroni), influendo in particolar modo sui sistemi modulatori che mediano funzioni quali il sonno, l‛attenzione o il meccanismo di punizione-ricompensa. Possiamo descrivere i sistemi modulatori come nuclei di neuroni capaci di modulare l‛attività di altri neuroni posti in altre regioni del cervello attraverso un particolare tipo di messaggero chimico. I principali sistemi sono: sistema noradrenergico, dopaminergico e serotoninergico. Le diverse sostanze agiscono in modo diverso sui sistemi modulatori, ad esempio gli allucinogeni, agiscono sul sistema serotoninergico mentre gli stimolanti agiscono sui sistemi modulatori noradrenegrici e dopaminergici.
La tossicodipendenza è stata descritta come un disturbo che si aggrava con il passare del tempo producendo alterazioni nel circuito di ricompensa e delle funzioni esecutive; la dipendenza può essere dunque definita come un ciclo ricorrente composto da tre fasi: l’abbuffata/intossicazione, l’astinenza/affetto negativo e la preoccupazione/anticipazione.
Gli studi di neuroimaging su animali e sugli uomini hanno evidenziato differenti circuiti cerebrali, cambiamenti molecolari e neurochimici, che riflettono le tre fasi del ciclo di dipendenza. In particolare, svolgono un ruolo importante diverse aree del cervello per ciascuna fase: l’area tegmentale ventrale e striato ventrale per la fase di intossicazione, le amigdale per la fase di astinenza mentre, una rete ampiamente distribuita che coinvolge la corteccia orbitofrontale è coinvolta nella fase di preoccupazione.
Nello specifico l’area tegmentale ventrale e striato ventrale sono aree del cervello deputate alla cognizione, motivazione e dipendenza da droghe; le amigdale (presenti una in ogni emisfero) sono strutture cerebrali situate all’interno del sistema limbico, ovvero, il sistema deputato nell’elaborazione delle emozioni e le manifestazioni vegetative che ad esse si accompagnano e nei processi di memorizzazione ed infine la corteccia orbitofrontale che, è parte della corteccia prefrontale, ha una grande importanza nella regolazione del comportamento sociale, del processo decisionale e dell’inibizione dei comportamenti.