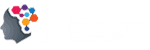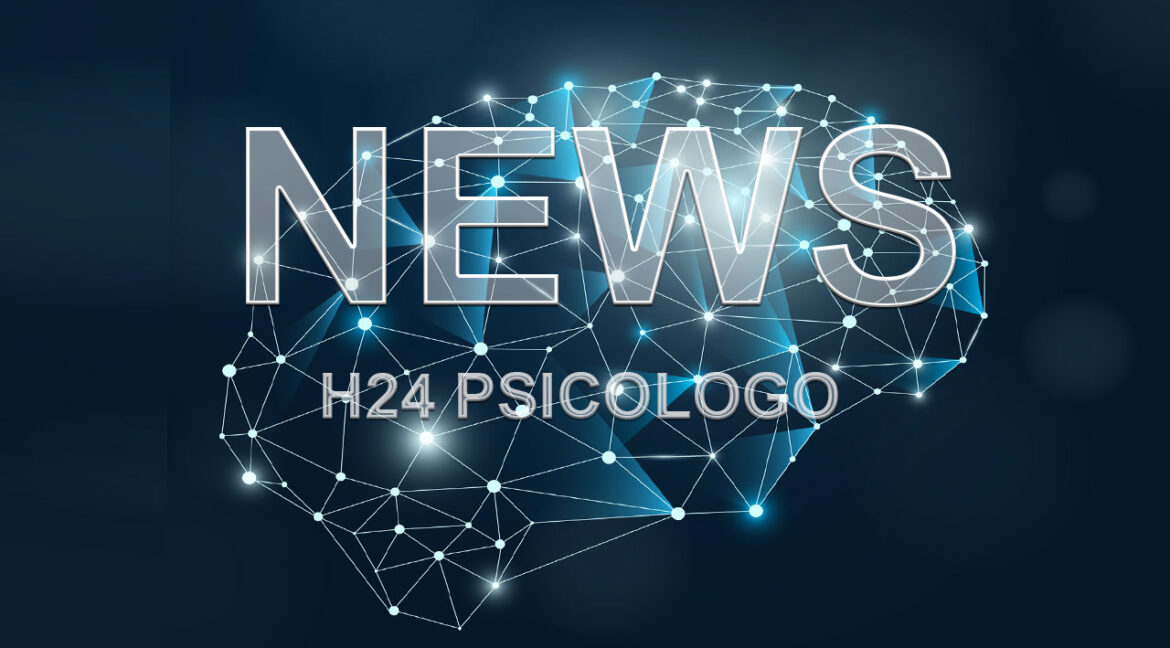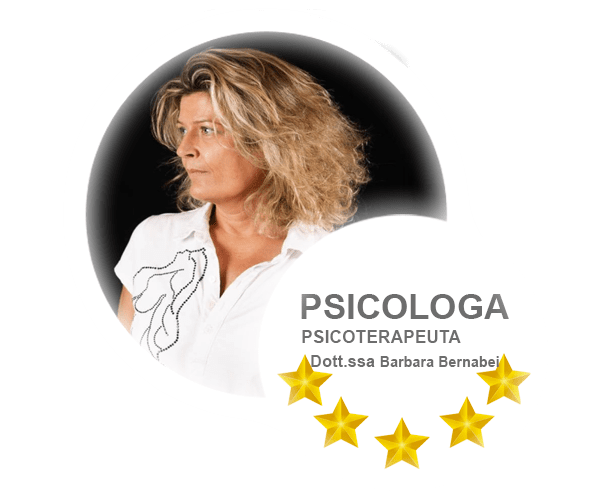Gli attacchi di panico rappresentano un’esperienza estremamente destabilizzante, caratterizzata da improvvisi e intensi episodi di paura apparentemente inspiegabili. Questi episodi si manifestano con sintomi fisici, come palpitazioni, sudorazione, tremori e sensazione di soffocamento, e sintomi cognitivi, come il timore di perdere il controllo, la paura di impazzire o di morire. Quando gli attacchi di panico diventano ricorrenti e il timore di sperimentarli di nuovo inizia a dominare la vita quotidiana, si parla di disturbo di panico. Questa condizione è caratterizzata dalla “paura della paura” e da comportamenti di evitamento che limitano notevolmente la qualità della vita di chi ne soffre.
Nonostante sembrino accadere come un “fulmine a ciel sereno”, la prospettiva basata sulla teoria dell’attaccamento offre una comprensione più profonda degli attacchi di panico, considerando il ruolo delle esperienze infantili nelle nostre reazioni emotive. Questo approccio rende possibile comprendere meglio le radici di questi episodi e trovare strategie efficaci per affrontarli.
Che cos’è l’attaccamento
John Bowlby ha definito l’attaccamento come un sistema comportamentale innato che si attiva per garantire la vicinanza a una figura di riferimento, fornendo protezione e sicurezza al bambino. Basandosi sulla teorizzazione di Bowlby, Mary Ainsworth ha condotto esperimenti noti come la “Strange Situation”, che alternano momenti di separazione e ricongiungimento tra il bambino e la madre. Sulla base del comportamento del bambino in questi momenti, Ainsworth ha individuato diversi stili di attaccamento: sicuro, evitante e ansioso-ambivalente (Ainsworth, 1978).
Ulteriori ricerche hanno dimostrato che lo stile di attaccamento sviluppato nell’infanzia influenza la nostra capacità di gestire lo stress e le relazioni future nella vita adulta (Francesetti, 2020). Se le interazioni con i caregiver sono state caratterizzate da prevedibilità, sicurezza e un senso di protezione, il bambino svilupperà un attaccamento sicuro. Al contrario, se queste interazioni sono state inaffidabili o incoerenti, si potranno sviluppare attaccamenti insicuri, evitanti o ambivalenti. Un bambino con un attaccamento insicuro avrà più difficoltà nell’attivare il sistema di esplorazione, che permette di muoversi nel mondo circostante con interesse e curiosità.
Attacchi di panico come rottura dell’attaccamento
Dalle storie dei pazienti emerge che gli attacchi di panico tendono a manifestarsi durante momenti critici di cambiamento, come fasi evolutive importanti, periodi di distacco, viaggi, trasferimenti o passaggi verso una maggiore autonomia e indipendenza. In queste situazioni di transizione, spesso percepite come minacciose, l’individuo tende a cercare conforto nelle figure di riferimento o a rifugiarsi in “luoghi sicuri”, come la propria casa. Questo stesso meccanismo di difesa si osserva frequentemente durante gli attacchi di panico, evidenziando come la tensione tra il bisogno di autonomia e quello di relazione giochi un ruolo centrale nella loro insorgenza.
Giovanni Liotti, nel suo libro “Sviluppi traumatici”, teorizza che il panico può essere interpretato come una rottura del senso di sicurezza e una manifestazione estrema di ansia da separazione. Liotti ha osservato che le persone con attaccamento insicuro sviluppano strategie di controllo per mantenere il legame “a tutti i costi” con la figura di riferimento, cercando di garantirsi protezione e sicurezza all’interno della relazione. Tuttavia, il fallimento di queste strategie può portare al panico, che rappresenta il momento in cui la persona percepisce l’incapacità di mantenere la sicurezza relazionale. Il panico, quindi, non deriva tanto da una crisi reale della relazione, quanto da un assetto relazionale e psicologico interno instabile, dove la rottura è immaginata o supposta (Liotti, 2017).
Chi ha vissuto un episodio di panico si sente vulnerabile, fragile e teme che l’evento possa ripetersi in situazioni pubbliche. Questo timore porta a ridurre il proprio campo d’azione, limitando le esperienze e ritirandosi in una zona di comfort percepita come sicura.
Meccanismi neurologici: il sistema di allarme di separazione
A livello neurologico, questa dinamica è stata studiata e osservata. Jaak Panksepp ha identificato l’esistenza di due diversi sistemi di allarme nel cervello: uno centrato sulla paura, connesso alla presenza di una minaccia percepita nell’ambiente, e l’altro sulla separazione, mediato da parti diverse del cervello. Il sistema della separazione si attiva in situazioni di distacco dal supporto affettivo, portando a risposte neurofisiologiche che includono alterazioni del respiro e del battito cardiaco, generando sintomi analoghi a quelli dell’attacco di panico. Questo suggerisce che il panico possa essere una reazione più legata alla separazione che alla paura.
Studi clinici dimostrano una connessione tra il disturbo di panico e l’ansia da separazione durante l’infanzia. La prevalenza del disturbo di panico è associata a una maggiore autonomia affettiva e a una maggiore esposizione ai cambiamenti ambientali (Francesetti et al., 2020).
La funzione del panico e la terapia
Durante un attacco di panico, il mondo può sembrare improvvisamente pericoloso, imprevedibile e incerto, riflettendo riflette le percezioni vissute nei confronti delle figure di riferimento nei primi anni di vita. I sintomi fisici intensi e il terrore apparentemente senza causa rendono difficile per la persona collegare questi momenti di intensa paura alle proprie esperienze emotive. Secondo Francesetti et al. (2020), questa incapacità di metabolizzare i segnali corporei e di collegarli alle emozioni e relazioni è alla base della persistenza degli attacchi di panico. In questo senso, gli attacchi di panico possono indicare difficoltà emotive profonde e rappresentare un’opportunità di crescita personale.
Il percorso terapeutico mira a dare un senso agli attacchi di panico, spesso percepiti come privi di significato. Attraverso la psicoterapia, il paziente imparerà a fidarsi delle proprie parti fragili e a sviluppare un senso di sicurezza interno. Questo processo include:
- Riconoscere i modelli di attaccamento insicuri e il loro impatto sulla vita attuale.
- Comprendere il significato personale dell’attacco di panico, ovvero ciò che esso comunica.
- Sviluppare una maggiore consapevolezza delle emozioni e delle reazioni fisiche e imparare a gestirle.
- Costruire un senso di sicurezza interno attraverso una relazione terapeutica stabile e di supporto.
Gli attacchi di panico, sebbene spaventosi, possono essere compresi e affrontati con successo attraverso la psicoterapia basata sulla teoria dell’attaccamento. Questo approccio trasforma il panico in un’opportunità di crescita, permettendo di costruire un senso di sicurezza e fiducia in se stessi e negli altri. Se soffri di attacchi di panico, considera di intraprendere un percorso terapeutico per trovare un nuovo equilibrio e benessere emotivo.
Riferimenti bibliografici
- Ainsworth, M. D. S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Lawrence Erlbaum Associates.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).
- Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. Basic Books.
- Francesetti, G., Ghiglione, E., Facondini, E., Gariglio, L., Gramaglia, C., & Bergese, R. (2020). Panic attack: Fear or solitude. Journal of Contemporary Psychotherapy(Francesetti-et-al-2020-…).
- Liotti, G. (2017). Sviluppi traumatici: Eziopatogenesi clinica e terapia della dimensione dissociativa. Raffaello Cortina Editore.
- Panksepp, J. (1998). Affective neuroscience: The foundations of human and animal emotions. Oxford University Press.
Psicologa Dott.ssa Anna Zucchi