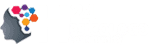Ognuno di noi può pensare di aver perdonato o di essere stato perdonato almeno una volta nella vita, ma siamo sicuri si trattasse davvero di perdono?
Possiamo parlare effettivamente di perdono solo nella condizione in cui si è ricevuta un’offesa. Il danno e la conseguente ferita, sia essa diretta o indiretta, deve essere considerata grave e ingiusta dalla persona che l’ha ricevuta.
L’importanza nell’atto del perdono riveste sicuramente importanza la responsabilità dell’offensore e se quest’ultimo ha commesso il danno volontariamente o involontariamente. Infatti, saremo più propensi a concedere il perdono nel caso in cui l’offensore abbia agito per condizioni cognitive compromesse, infantilità, costrizione (forze di causa maggiore) o ignoranza, rispetto alla situazione in cui la persona ha agito intenzionalmente e consapevolmente non vincolato da cause esterne o disinformazione. Inoltre, saremo più inclini al perdono se l’offensore dimostrasse pentimento, risentimento, colpevolezza o sentimento di responsabilità per l’offesa arrecata, rispetto a chi ci ha fatto un danno e non riconosca il torto o non si senta responsabile.
Un altro aspetto importante legato al perdono è la dimensione temporale. Il perdono essendo un processo molto complesso ha bisogno di tempo, anche se non è il tempo che garantisce lo sviluppo del perdono. È importante dunque rispettare dei tempi per perdonare e per richiedere il perdono. Più grave è l’offesa e la nostra ferita, più tempo avremo bisogno per perdonare: concedere il proprio perdono prematuramente o sentirsi obbligati (anche se è impossibile perdonare se non esercitiamo la nostra libertà di scelta) a perdonare potrebbe svalutare la ferita o causare problemi di altra natura.
Da quanto visto finora dunque non si parla di perdono quando riceviamo offese di scarsa importanza e rispondiamo a queste con indifferenza e giustificazioni. Nell’indifferenza, possono rientrare casi in cui l’atto offensivo non rientra nella sfera dell’immortalità dell’individuo e quindi non sorgono la colpa e neanche il perdono mentre, quando giustifichiamo e scusiamo l’atto e la persona che l’ha commesso, tendiamo a minimizzare l’offesa dando spiegazioni del torto subito.
Diversi sono gli studiosi che si sono interessati al perdono. Esistono differenti definizioni di perdono che si accomunano da un unico aspetto: il cambiamento. Il perdono, infatti, è un processo verso il cambiamento in cui una persona, che è stata ferita, offesa o trattata in modo ingiusto, abbandona i sentimenti negativi, le emozioni e i comportamenti correlati al danno subito, e talvolta all’offensore, riuscendo a traslatarli in emozioni e comportamenti positivi.
Il perdono è dunque un cambiamento presociale che si basa sul principio morale di benevolenza che racchiude in essa l’amore profondo, la compassione, la generosità e altri sentimenti benevoli. Il perdono può essere considerato un dono verso chi ci ha ferito ingiustamente o verso noi stessi, perché ci permette di ridurre i pensieri e le emozioni di vendetta, ostilità, risentimento che a loro volta innescano meccanismi di mantenimento di emozioni e comportamenti negativi che destabilizzano il nostro benessere psicofisico.
Possiamo parlare di perdono verso gli altri e di perdono verso se stessi. In quest’ultimo caso il percorso intraindividuale del perdono permette di perdonare se stessi e assottigliare le emozioni negative di rabbia, colpa e vergogna per aver commesso un danno ad altri o a se stessi o per aver violato i propri valori morali. Il processo del perdono concede a chi perdona un’occasione per avere un nuovo spazio per vivere la propria realtà e il proprio presente, permette di acquisire e aggiungere nuovi valori al nostro essere e nuove strategie per affrontare le difficoltà.